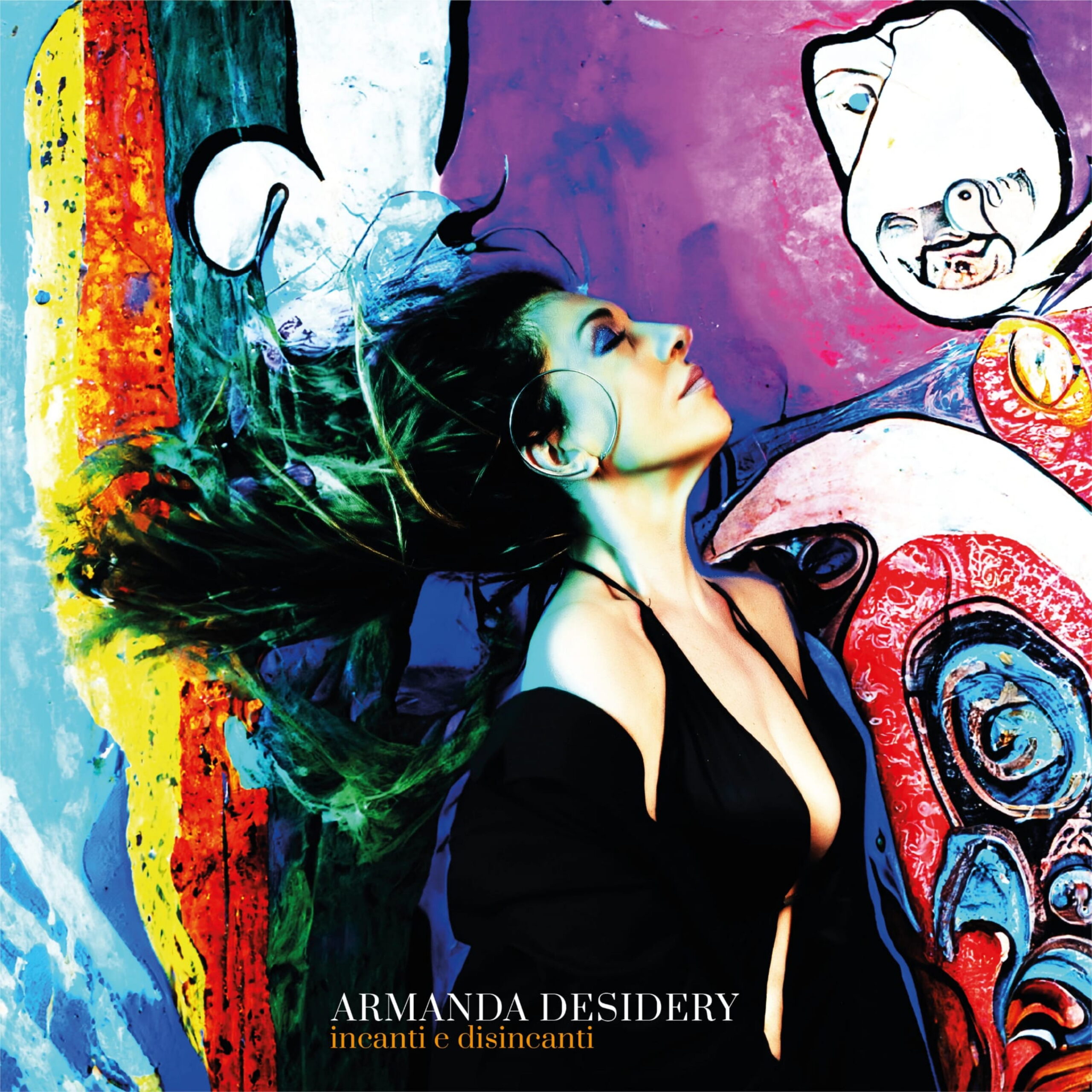Eddington, New Mexico, Maggio 2020. Nel pieno della pandemia di Covid-19, lo sceriffo Joe Cross (Joaquin Phoenix) è in rotta col sindaco Ted Garcia (Pedro Pascal) per le misure di distanziamento sociale da lui introdotte, nonché per le concessioni a un conglomerato che ha scelto la cittadina quale sede per il suo nuovo data center. La decisione di Joe di candidarsi a sindaco è solo l’inizio di una spirale di violenza e isteria che avviluppa la comunità di Eddington.
Benvenuti nel deserto del reale.
Jean Baudrillard
Uno strano e originale percorso ha dettato e guida tuttora l’evoluzione registica di Ari Aster: inizialmente affermatosi, come i colleghi Robert Eggers e Oz Perkins, nell’alveo della rinascita folk horror, il regista di Hereditary (2018) e Midsommar (2019) ha saputo scartare a lato, enfatizzando lo psicologismo e il realismo magico della sua scrittura filmica entro una forma nuova e trasversale del suo cinema. Già il divisivo Beau ha paura (2023) era in tal senso un’inclassificabile mistione di horror, dramma surrealista e fantasia kafkiana, sovente trainato più dal gusto per la divagazione e la fantasticheria che dalle necessità del racconto tradizionale. Ciò non compensa, semmai moltiplica, la sorpresa di chi assiste a Eddington, opera con la quale il regista più “europeo” (per suggestioni e approcci) della nuova generazione affronta la materia più americana che ci sia, allontanandosi ancor più dall’orrore all’atto di imbastire un bizzarro western contemporaneo.
Dunque il western, ma come? Quale collegamento può mai esservi tra l’espansione americana a Ovest e il collasso economico, sociale e umano della pandemia che ci ha tenuti chiusi in casa tanto a lungo? Va premesso: onore ad Aster per aver preso la questione di petto, entro un cinema ancora restio ad affrontare un evento situato scomodamente sulla soglia tra cronaca e storia.
Che sia proprio questa la chiave? In fondo la pandemia non ha fatto (salvo naturalmente i milioni di morti) che ridefinire leggi e consuetudini, tribalizzare il tessuto sociale, creare frontiere nuove sul cui limite ri-mappare un territorio umano riscopertosi selvaggio; la lotta tra il vecchio e il nuovo – sia questo la ferrovia, il distanziamento sociale o l’avanzata delle Big Tech – è sempre stata il centro febbricitante di un genere che oppone leggi centrali e periferiche, la giustizia istituzionale e l’eterno medioevo interiore. Roba che sa davvero aggiungere il folk all’orrore, che sa riscoprire, a favore di occhi nuovi, la più banale comunità di provincia quasi fosse uno strano culto silvano.
Eddington riesce a modellarsi quale straordinaria summa di cinque anni di isteria: teorie del complotto, paranoia diffusa, la sfiducia verso un governare sempre più lontano da masse abbrutite, incattivite, pronte a farsi massa critica di nuovi autoritarismi. C’è un po’ di tutto, dal coronavirus alla morte di George Floyd, da Black Lives Matter al traffico di minori, all’ineludibile confronto con un convitato non già di pietra, bensì di silicio, messaggero di un futuro che vende promesse di ordine, trasparenza, progresso.
Aster è clinico e insieme empatico, non demonizza né giustifica: entomologico e sardonico, il suo occhio registico percorre in lunghi piani-sequenza un habitat depauperato e lo seziona una casa, un ufficio, un supermercato per volta. La forma filmica è limpida come in Midsommar, lo stile è austero e tuttavia arioso: luce diffusa, camere fisse, pochi e significativi primi piani. Su tutto l’ironia, i violenti contrasti tonali, la dissonanza: Cross e Garcia faccia a faccia come in un film di Leone, mentre una canzonaccia di Katy Perry sfonda il silenzio del deserto oltre il recinto. Violenza fredda, non clinica ma spassionata, comprimari distaccati e cavillosi, dialoghi da ginnastica mentale mal praticata.
Non tutto funziona alla perfezione: a volte Aster coreografa il caos con troppa nettezza, riprende una rissa come uno scontro di pupazzi in mano a un bambino; a volte il budget stringe, la relativa pochezza dei mezzi non rende sempre giustizia a un’immagine che vorrebbe incarnare il caos e deve accontentarsi di un picchetto. Pazienza: ogni volta che può il regista si chiude in casa coi suoi attori, fa implodere la guerra nel microcosmo domestico, trattiene il piano della ripresa sulla sfumatura d’ambiente, sulla recitazione che qui tocca apici assoluti. Merito anche di Joaquin Phoenix, della sua dedizione assoluta al vestire i panni di uno sceriffo conservatore, un inadeguato con pistola al fianco; un personaggio il quale, nonostante incarni tutto quel che temiamo di diventare, quasi farebbe simpatia. Intorno a lui Emma Stone, Deirdre O’Connell, un inquietante e messianico Austin Butler, infondono vita, complessità e colore a un ritratto di umanità alla deriva sull’orlo della caricatura.
Quello di Aster è un cinema in tutto e per tutto apocalittico: non solo apocalisse come fine, ma come rivelazione e residuo; l’Apocalisse, dice Deleuze, è il libro di chi si crede superstite. Ne è prova la guerra che atterra su Eddington via drone; impossibile imporre ordine al caos, suturare la ferita su cui la collettività nuova, arrabbiata e disillusa, crescerà se stessa. Il tocco di classe è l’aftermath: l’umanità è storpia e senza voce, chi prometteva guerra al sistema si è venduto; il nuovo avanza e gli avanzi stanno a guardare. Lontano, nel buio di un deserto lunare, qualcuno non ha smesso le armi, sperando nella prossima apocalisse.
Fabio Cassano
Leggi anche al link https://madmagz.app/viewer/68fbb2a8321edd00148d34ba